Cacio, basta la parola
Nel cuore d’Italia si produce formaggio da tremila anni. È una lunga storia, intessuta di passione e leggende, “sapienza delle mani”, tradizioni antiche e tecniche di lavorazione tramandate dai pastori per secoli, da padre in figlio.
È il caso di dire che per il formaggio dell’Umbria basta la parola. Una parola: kuat-s-ejo. Così gli umbri, il più antico tra i popoli italici, del quale è rimasta una straordinaria testimonianza scritta impressa sul bronzo delle Tavole Eugubine, chiamavano il caglio, l’elemento misterioso che fermenta e poi diventa formaggio.
Nell’affascinante lingua di quei pastori, avvezzi già da allora alle lunghe transumanze, con ogni probabilità quella parola si pronunciava “casio”.
I latini, nipoti degli umbri, lo chiamarono caseus, il termine dal quale è nato il nostro “cacio”. La radice del nome è indoeuropea: kuat. Vuol dire, appunto, “fermentare, inacidire”, da cui kuat-so (“fermento, lievito”). Così, a partire dal lontano “casio” umbro e dal latino “caseus”, sono nati, via via, il tedesco “käse” e l’inglese “cheese”. Ma anche l’irlandese arcaico “cais”, il gaelico scozzese “caise” o il celtico “caashey”. Oppure il gallese “caws”, l’antico bretone “keuz” o il rumeno “caş”. Fino allo spagnolo “queso” e al portoghese “quejo”.
Furono però i greci a dare a questo meraviglioso alimento il nome che ancora oggi lo identifica. Lo chiamarono “formos”, dal paniere di vimini dove quel latte cagliato veniva messo in forma. La parola italiana “formaggio” è invece un prestito “di ritorno” dal francese. Arriva dal tardo latino “formaticum” che indicava l’alimento che stagionava nelle forme. Nel francese antico era definito “fromatge”. Poi, nei secoli, passando dai Franchi ai Francesi, si affinò in “fromage”.
Un nome piacevole, che indica, in senso lato, centinaia di varietà e di tipologie, ognuna con la sua storia particolare. Tanto da far dire un giorno a uno spazientito De Gaulle, intervistato da un cronista di Newsweek: «Come si può governare un Paese che ha 246 tipi differenti di formaggio?».
Forse, per questo, governare gli italiani è ancora più difficile: nel Belpaese lo storico dell’alimentazione Corrado Barberis ha censito addirittura 402 diverse tipologie ufficiali di formaggi.

Pecorino di Norcia
ALL’INIZIO FU IL PECORINO Il primo cacio italiano, quello più antico, che in Umbria la fa ancora da padrone, è il pecorino, che, con ogni probabilità, fu anche il primo a essere prodotto dall’uomo. Proprio perché la pecora fu il primo mammifero a essere addomesticato.
Del resto, Abele, l’innocente fratello di Caino, figlio di Adamo e di Eva, era un pastore. E l’agnello, simbolo di innocenza e purezza, nella cultura ebraica è la vittima sacrificale per eccellenza. Durante il rito si beveva il latte raccolto nel quarto stomaco dell’agnello sacrificato. Nelle cerimonie, sempre più affollate di fedeli, del latte fu diluito in altro latte. La coagulazione enzimatica che ne seguì produsse il “caseus pecus”, precursore del formaggio.
Un bassorilievo sumero di cinquemila anni fa, il “Fregio della latteria”, è la testimonianza più antica del prezioso alimento: raffigura esperti caseari, non a caso dei sacerdoti, impegnati nelle consuete operazioni di mungitura.
Così, tra il mito e la magia, il formaggio è giunto sino a noi. Una leggenda, raccontata per secoli in tutta l’Asia Minore, parla di un mercante che nell’attraversare il deserto portò con sé del latte in una bisaccia che era stata ricavata dallo stomaco di una pecora: il caldo, il movimento e gli enzimi del contenitore finirono per rendere acida la bianca bevanda.

Il fregio della latteria, bassorilievo sumero del III millennio a.C.
Un’alchimia. Batterica e quindi misteriosa. Capace di trasformare un liquido che deperisce in una massa solida, nutriente e gustosa. Qualcosa che si può conservare nel tempo. Dovette sembrare quasi un miracolo.
In un celebre passo della Bibbia la lavorazione del latte è paragonata a un feto che cresce nel grembo materno. Giobbe dice a Dio: «Mi hai fatto colare come latte e mi hai cagliato come formaggio». La nascita del prodotto affonda nelle nebbie della Storia. Secondo i Greci, Aristeo, figlio di Apollo, apprese l’arte della pastorizia e dalla cagliatura dalle Ninfe. Addirittura, nei Veda, la raccolta in sanscrito dei testi sacri dei popoli arii che invasero l’India settentrionale, gli dei e l’universo «nascono da un oceano di latte zangolato (cioè sbattuto, come la crema per fare il burro) da Visnù».
Sul formaggio i popoli nomadi del Medioriente e del Mediterraneo fondarono la loro economia. E nell’Odissea Omero descrive il primo caseificio della storia: è l’antro dove lavora e dorme il Ciclope, la casa del malvagio Polifemo che vuole mangiare Ulisse e i suoi compagni, magari insieme al vino e al cacio che produce in grande quantità: «I graticci erano gravati dai formaggi, nei recinti si affollavano agnelli e capretti […]. I recipienti ben fatti, secchi e tinozze, nei quali mungeva, erano tutti pieni di siero»
Nella dieta dei Greci il formaggio era un alimento ricercato. Atene già nel V secolo a.C. lo importava con regolarità dalla Sicilia. Lo stesso Giove, secondo la mitologia, era stato allattato da una capra. E il cacio di pecora era l’alimento destinato a trasmettere energia agli atleti olimpici. Un cibo prezioso. Tanto che Esopo, l’iniziatore della favola come forma letteraria scritta, in un suo celebre racconto fa ingolosire una volpe che, prima dell’agognato banchetto, adula e deruba un corvo vanesio di un prezioso tocco di formaggio giallo.
IL CELEBRE FORMAGGIO DEGLI ANTICHI UMBRI Esopo parlava di un cacio di pecora. Come quelli che nello stesso periodo venivano lavorati dai pastori che abitavano l’Italia di allora. Con l’antica Umbria in prima fila. Ce lo ricorda Plinio il Vecchio, che nella “Storia Naturale”, parlando della provenienza e della qualità dei maggiori formaggi allora conosciuti a Roma, decanta la bontà del pecorino “sarsinate”, che era prodotto oltre la sorgente del Tevere, sui monti dell’Appennino, nei pascoli intorno alla città di Sarsina, fondata dagli antichi umbri, ben 400 anni prima di Cristo.
All’epoca, quel formaggio era considerato il cacio per eccellenza: fu apprezzato in tutto l’impero romano e cantato da Marziale che lo consumava ogni giorno nel suo jentaculum, il pasto quotidiano a base di pane e prelibati formaggi «a forma di cono che grondano latte».
Il cacio alleviava la fatica. Durante le marce faticose o prima di andare in battaglia, i legionari romani aggiungevano sempre un’oncia di pecorino alla loro quotidiana razione di farro.

Il Caciofiore, formaggio dell’Antica Roma realizzato con latte di pecora e caglio vegetale ottenuto dal fiore di carciofo o di cardo selvatico, descritto da Columella. Fotografia di Paolo Groppo
Gli Umbri, popolo di pastori, avvezzi alle transumanze, già allora producevano, consumavano ed esportavano in tutta la penisola il loro famoso pecorino. L’umbro sarsinate Plauto ne era ghiotto. E lo citava di continuo. Tanto che anche alcuni personaggi delle sue celebri commedie, vengono tratteggiati con affettuose espressioni come «formaggino mio» (meus molliculus caseus) oppure «caciottino mio dolce» (dulciculus caseus).
Nella lavorazione del formaggio dell’antica Umbria anche gli Etruschi diedero il loro contributo: usavano cagli di tipo vegetale come il cardo e il fico. Tecniche innovative che poi furono trasmesse ai Romani, che però, pur consumando formaggio in quantità, lo consideravano un cibo rustico, non adatto alle classi dirigenti. Tanto che Trimalcione nella sua celeberrima cena, non pensò di offrire formaggio ai suoi ospiti.
Ma c’erano lodevoli eccezioni. Come Marco Terenzio Varrone, nato a Rieti e proprietario di fattorie e terreni in Valnerina, che decantava il formaggio ottenuto dal caglio di capretto o di lepre anziché di agnello. E come l’imperatore Ottaviano, che conquistò Perugia, la incendiò e la ricostruì e poi le concesse il titolo di “Augusta” ma che anche durante i giorni tormentati del bellum Perusinum, si nutriva in modo frugale con «formaggio di vacca pressato a mano e fichi fioroni».
Lucio Giunio Moderato Columella, il grande scrittore romano de “L’arte della coltura”, fu anche un fattore, con molte proprietà nell’Italia centrale, da Carsoli ad Albalonga. Il suo trattato “De re rustica”, in dodici volumi, ci è pervenuto integro: è la maggiore fonte di conoscenza sull’agricoltura romana. Columella parla molto del formaggio. E dà anche la ricetta del “moretum” che Virgilio adorava: «Al formaggio fresco e salato aggiungi santoreggia, menta, ruta, coriandolo, sedano, porro o cipolla novella, lattuga, foglioline di rucola, timo fresco o nepetella, o anche mentuccia fresca; mescola e condisci con poco aceto e pepe e un filo d’olio. Di volta in volta si possono aggiungere come varianti noci ben mondate o sesamo leggermente tostato». Il grande poeta mantovano parla del formaggio nelle Bucoliche come di una prelibatezza da offrire alle persone più care: «Potevi riposare questa notte con me/su verdi foglie; noi abbiamo frutti maturi/tenere castagne e abbondanza di formaggio».
L’epopea del pecorino finisce con le invasione barbariche che cambiano le abitudini alimentari. I popoli germanici erano grandi allevatori di mucche. Goti, Vandali e Franchi, si cibavano quasi esclusivamente di carne, latte e formaggio. E anche i Romani, che disprezzavano quei barbari golosi di latte di vacca, cominciarono a ricredersi.
Saranno comunque i seguaci della regola di San Benedetto da Norcia a introdurre nuove tecniche e a sviluppare l’arte casearia. Molti prelibati formaggi nasceranno proprio dal divieto assoluto di consumare carne contenuto nelle severe regole degli ordini monastici. Nelle vaste proprietà terriere che sorgevano intorno ai monasteri, si misero a coltura nuovi pascoli e l’arte della caseificazione, piano piano, si raffinò: il formaggio iniziò a essere prodotto in grandi quantità e diventò una fonte alternativa preziosa di proteine nella magra dieta dei popoli medievali. Un cibo nutriente e a buon mercato.
Ma la scienza medica del Medioevo guardava ancora con sospetto ai meccanismi “alchemici” della coagulazione e della fermentazione. Un aforisma, attribuito alla Scuola Salernitana, diventò il luogo comune della letteratura igienico-sanitaria del Basso Medioevo: «Il formaggio non fa male solo se è mangiato a piccole dosi». Non la pensava così la maggior parte della popolazione per la quale, in tutta l’età di mezzo, la dieta a base di formaggio rappresentò la principale fonte alimentare di proteine animali.
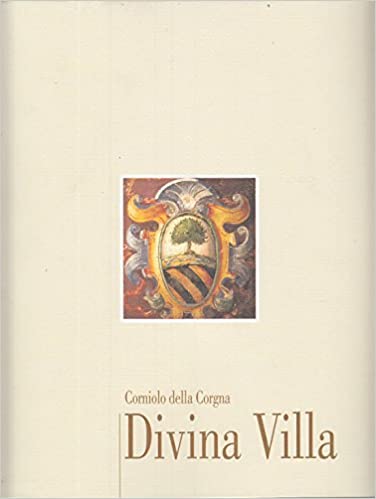
Copertina del trattato di Corniolo della Cornia
CORNIOLO DELLA CORNIA E LE REGOLE DEI MAESTRI CASEARI Uno dei più grandi divulgatori dell’arte di fare il formaggio fu un altro umbro, Corniolo della Cornia, agronomo vissuto alla fine del XIV secolo. Era un possidente perugino che ebbe il merito di scrivere in lingua volgare un trattato di agricoltura in dieci libri, la “Divina Villa”, nel quale tramandò le regole dei mastri caseari dell’epoca. Parlò a lungo del pecorino e della tradizione dell’antico formaggio in Umbria, insieme ad altre tematiche legate alla vita dei campi. Ebbe un tale successo che i suoi didascalici insegnamenti in fatto di agricoltura furono ripresi per secoli da molti altri autori.
Il cacio nel Trecento era qualcosa in più di un alimento: per centinaia di migliaia di poveri era anche un segno di una ricchezza raggiungibile, vicina. Momentanea, certo. Ma commestibile e concreta. Un sogno da sognare a occhi aperti. Qualcosa simile al Paradiso. Tanto che Boccaccio, nel Decamerone, descrive così il Paese dei Bengodi: «Ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan, che fare maccheroni e raviuoli e cuocergli in brodo di capponi».
Quasi un secolo dopo, l’umanista e gastronomo Bartolomeo Sacchi, detto Il Platina, che in un breve trattato di gastronomia, scritto poco dopo la metà del Quattrocento, già propugnava “il cibo del territorio”, mise sotto accusa il formaggio stagionato, che a suo dire faceva male.
Difendeva invece quello fresco che «nutre molto e in maniera efficace, calma l’infiammazione dello stomaco e giova agli ammalati di tisi». Il Platina stilò anche una classifica dei formaggi: metteva al primo posto quelli di capra, poi quelli di pecora e solo in fondo quelli prodotti da latte di mucca. Fra le sue tante prescrizioni, scolpì una legge dello stare bene a tavola che è arrivata fino a noi: quella che raccomanda di consumare cacio sempre alla fine del pasto, «finché la bocca non sa di formaggio».
La regola persiste. Con vari proverbi annessi, tra i quali spicca un famoso detto, declinato dal nord al sud della penisola in una miriade di dialetti diversi: «La bocca non è stracca se non sa di vacca». Anche perché, lo sapevano già i Romani, mangiare formaggio alla fine delle altre portate, fa venire sete. E il vino, allora, come oggi, piaceva quasi a tutti.
In pieno Rinascimento, per la precisione nel 1477, un medico piemontese, Pantaleone da Confienza, diede alle stampe il primo trattatello organico europeo sul latte e sui formaggi: la “Summa lacticiniorum”. Nella prefazione, Pantaleone sembra quasi giustificarsi con il lettore: «Tratto un argomento rozzo». Ma invece descrisse e catalogò con precisione tutti i formaggi conosciuti all’epoca. Criticò indirettamente i medici, ancora scettici sulle virtù del cacio e molti nobili che ancora storcevano il naso, scrivendo di aver conosciuto «reges, duces plurimos, comites, marchiones, barones, milites, nobiles et mercatores» ghiotti dell’alimento. Quanto ai poveri, i loro formaggi «grazie al pizzicore sono dispensati dall’usare spezie e sale», sostanze all’epoca preziose e di difficile reperimento che non figuravano certo sulle mense popolari.
Il pregiudizio rimaneva. «Tutti i casci sono di tristo succo, eccetto ch’i freschi», precisava nel XVI secolo il medico bolognese Baldassarre Pisanelli. Per lui, il formaggio «come s’invecchia, diventa pessimo». Ma Leonardo Fioravanti, medico, chirurgo e alchimista, bolognese anche lui, spiegava che nemmeno i luminari dell’epoca erano convinti di queste prescrizioni: «Non si truova gente al mondo che creda manco alla medicina quanto facciamo noialtri medici».
 IL FORMAGGIO CON LE PERE DI CASTORE DURANTE Fu un umbro che diede una patente di dignità al formaggio: Castore Durante di Gualdo Tadino. Era un medico e un poeta ma anche un raffinato botanico. Scrisse l’“Herbario Novo” e “Il Tesoro della sanità”, un’opera che conteneva molti preziosi suggerimenti dietetici. Castore era così famoso e apprezzato da curare la salute di papa Sisto V. Ricordando i formaggi della sua infanzia, nell’Umbria odorosa di pascoli, esaltò le virtù gastronomiche e terapeutiche dell’alimento.
IL FORMAGGIO CON LE PERE DI CASTORE DURANTE Fu un umbro che diede una patente di dignità al formaggio: Castore Durante di Gualdo Tadino. Era un medico e un poeta ma anche un raffinato botanico. Scrisse l’“Herbario Novo” e “Il Tesoro della sanità”, un’opera che conteneva molti preziosi suggerimenti dietetici. Castore era così famoso e apprezzato da curare la salute di papa Sisto V. Ricordando i formaggi della sua infanzia, nell’Umbria odorosa di pascoli, esaltò le virtù gastronomiche e terapeutiche dell’alimento.
Nel suo trattato medico-gastronomico vergò parole che allora apparvero definitive: «Il nocumento del cacio si può ridurre mangiandosi seco in compagnie di pere». Da questa autorevole indicazione alimentare nacque il celebre proverbio che tutti conoscono: «Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere».
Infatti, all’epoca, il cacio era soltanto il cibo dei poveri: pastori e contadini lo consumavano nelle faticose transumanze e nella grama vita di tutti i giorni. Una vivanda trasportabile, che si poteva conservare per mesi. E che, soprattutto, dava l’energia per affrontare i duri lavori dei campi. Le pere, invece, erano un lusso, una ricercatezza. Deperibile e lussuriosa: un vero status symbol nelle mense imbandite dei ricchi. Un frutto delicato, da trattare con cura. Tanto che qualche giovin signore con slancio gastronomico e poetico insieme, le paragonava «al corpo di una gentildonna». Fu quindi grazie a Durante, colto medico gualdese, che la barriera classista del gusto, dopo tre secoli di pregiudizi, iniziò a sgretolarsi. Quel prezioso alimento riprese il ruolo che aveva avuto per migliaia di anni: una delizia per ogni palato e un sicuro passaporto per la salute.
Ma Castore non dimenticava la sua Umbria e nelle prescrizioni mediche, rivolte soprattutto a chi sapeva leggere e quindi solo a qualche nobile e ai sacerdoti, ammoniva i contemporanei e tra le righe del suo “Il Tesoro Della Sanità”, scriveva: «Il pecorino è il megliore degli altri». È la prima citazione del famoso formaggio, nell’anno di grazia 1586.
Comunque sia, da allora il cacio trovò altri estimatori. Fra i tanti, merita una citazione il ferrarese Ercole Bentivoglio, che nelle terzine della sua “Lode del Formaggio” cantò con abili rime: «Formaggio è il primo nutrimento umano, sprezzato sol da gente cieca e grossa, che dice che gli è pasto da villano. Perché la forza ne mantien dell’ossa e non cred’io che l’uom senza mangiarne, compiutamente esser gagliardo possa». Il cacio come riserva di proteine nobili, che, a detta dell’Ercole ferrarese, sprigionava qualità afrodisiache. Bentivoglio lo mise addirittura per iscritto, strizzando l’occhio al lettore: «L’amante tutta notte si dimena senza posarsi mai con la sua amica s’egli un buon pezzo n’ha mangiato a cena».
E a proposito di femmine, Brillat Savarin, cuoco raffinato e scrittore francese del Settecento, autore della fondamentale “Fisiologia del gusto”, calcava sulla bontà dell’argomento con slogan simili a quelli dei moderni guru del marketing: «Un fine pasto senza formaggio è come una bella donna senza un occhio».

Dipinto Anonimo sul formaggio nell’Ottocento
IL CACIO, RISORSA DELL’UMBRIA Nello stesso periodo, agli inizi del Settecento, l’avvocato perugino Angelo Benucci, in una sua apprezzata relazione stilata per il catasto, prese atto di un importante mutamento sociale: in tutte le zone dell’Umbria la produzione di cacio era tale da essere ormai diventata una delle principali risorse economiche della regione.
Nel secolo dei Lumi l’arte casearia fu nobilitata da imprimatur scientifici. Nacquero formaggi nuovi, di qualità sempre migliore. La produzione cresceva insieme al consumo. Poi nell’Ottocento in tutta l’Europa si sviluppò un nuovo culto della cucina. E quello che era stato, per secoli, “il cibo dei poveri” diventò il segno distintivo delle ricette più creative e originali.
Adesso, in Umbria e nel mondo, tutti sanno ormai «quanto è buono il formaggio con le pere». E lo apprezzano anche quando si sposa con altre delizie. Come quando è abbinato ai fichi, al miele, alle marmellate, alla frutta e alle fresche verdure di stagione. Nelle classifiche del gusto, lungo i mari di Internet, tra blog e rubriche, e nei mille programmi tv, rimbalzano gusti e ricette, succulente o strampalate, per ogni abitudine e per tutte le tasche.
Fra i suoi tanti tesori, l’Umbria offre a chi la visita la garanzia di un cacio genuino. Un formaggio tradizionale e forse, proprio per questo, imbattibile. Recenti ricerche mediche confermano quello che gli abitanti della regione sperimentano da secoli: un equilibrato consumo di pecorino fa bene. Ne bastano piccole quantità per proteggere l’organismo dall’arteriosclerosi. Contiene un acido grasso, il Cla, che è una sorta di scudo naturale contro il cancro. E l’alto livello di Omega-3, come hanno dimostrato qualificate ricerche cliniche, assicura benefiche proprietà antinfiammatorie.

Fotografia dal libro L’Umbria dei Formaggi
I pastori dell’Umbria ricordano che un grande formaggio ha bisogno di prati profumati, di boschi e di pascoli ancora incontaminati. Poi serve la sapienza antica dei maestri caseari, che va miscelata con il tempo giusto, quello che serve per ripetere un miracolo.
I moderni esploratori del “cuore verde d’Italia”, come gli antichi legionari romani, si accorgono in fretta che spesso basta poco per stare bene: un’oncia di pecorino e un bicchiere di vino. Bianco se il formaggio è fresco, rosso se il cacio è stagionato. In ogni caso, sarà un pasto da ricordare.
Federico Fioravanti



